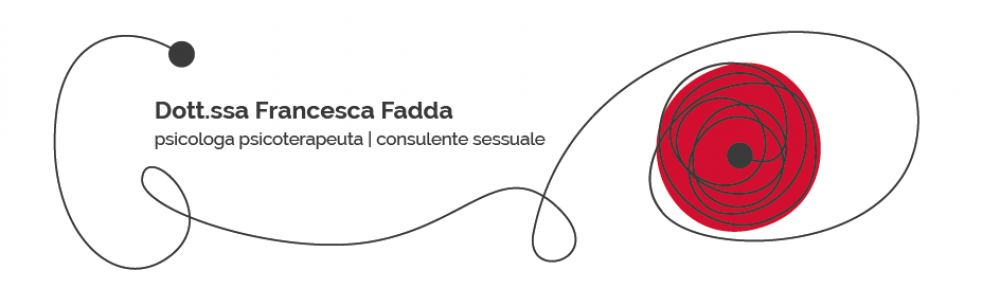Nell’immaginario collettivo figli unici e figlie uniche vengono dipinti e dipinte per vizi, egoismo, isolamento e disadattamento. Andando oltre gli stereotipi le loro famiglie raccontano molto di più sul nido di relazioni che si intrecciano attorno a quell’Unico, tanto amato e conteso.
Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo
(Leone Tolstoj)
Il progressivo calo demografico che ha caratterizzato l’assetto sociale degli ultimi decenni, in Italia in particolare, ha lentamente prodotto una trasformazione della famiglia riscontrando una tendenza delle giovani coppie a scegliere di orientarsi verso un unico figlio o un’unica figlia. Un articolo pubblicato recentemente su La Repubblica riporta alcune statistiche secondo le quali oltre il 46% delle famiglie italiane è costituito da un nucleo di tre componenti.
La condizione di figlia e figlio unico è tipica di bambini e bambine che crescono senza fratelli o sorelle e che, per questo motivo, possono sviluppare specifiche dinamiche a livello di personalità e a livello familiare.
Il fatto di vivere esclusivamente con figure adulte può attivare un processo di adultizzazione che porta il figlio unico e la figlia unica ad assumere precocemente ruoli adulti, con un carico di impegni e preoccupazioni inadeguati per la fase del ciclo di vita e per il ruolo occupato all’interno della famiglia. L’attribuzione del potere genitoriale può funzionare solo in casi particolari, esclusivamente se la delega dell’autorità al figlio o alla figlia viene esplicitata e se sono condivise e dichiarate le motivazioni e i compiti che derivano da tale delega. Per esempio, se la madre o il padre hanno temporaneamente un impedimento ad esercitare alcune attività familiari può essere chiesto al figlio o alla figlia di occuparsene, compatibilmente con le risorse che ha a disposizione, in base all’età e alle capacità, in maniera chiara, circoscritta e contestualizzata. Una famiglia può incontrare invece difficoltà se la delega dell’autorità non è esplicita o se i genitori abdicano al loro ruolo lasciando che il figlio o la figlia diventino la fonte principale di guida, controllo e decisioni. In questi casi le richieste possono scontrarsi con i bisogni propri dell’età e oltrepassare le capacità di sostenerle.
Le famiglie a Tre sono particolarmente sensibili a queste dinamiche, il confrontarsi dei figli prevalentemente con figure adulte può rendere i confini tra il sistema genitoriale e quello figliale poco chiari, determinando una comunicazione e una negoziazione delle regole di vita da pari a pari, privando il figlio o la figlia del contenimento e delle sicurezza offerti dall’esercizio del potere e dell’autorevolezza genitoriale.
I figli unici adultizzati generalmente crescono con un grande senso di responsabilità, tendono a controllare che tutto sia a posto, sono timidi e rispettosi, a scuola collaborano per il rispetto delle regole, giocano con ordine e lealtà. Questo comportamento maturo e serio risulta apprezzabile ed è fonte di gratificazione, soprattutto per parenti e insegnanti, ma può trarre in inganno perchè rischia di nascondere una forte paura di sbagliare, di deludere le aspettative altrui, ma anche dipendenza, insicurezza e bassa autostima. Il senso di sicurezza viene sperimentato infatti soltanto nell’ambiente familiare, considerato come luogo protetto rispetto al mondo esterno pieno di situazioni incerte e pericoli.
Il figlio unico e la figlia unica socializzano prevalentemente attorno agli adulti, trascorrono la maggior parte del tempo con i genitori, i parenti e gli amici dei genitori, imparando ad imitarne le abilità e i modelli comportamentali. Intrattenendo più relazioni con i genitori che con il gruppo dei pari, sviluppano maggiormente relazioni in linea verticale che orizzontale. Le relazioni che il figlio unico stabilisce all’interno della sua famiglia, saranno sempre con una figura adulta: madre-bambino/a, padre-bambino/a, madre-padre-bambino/a. Il figlio unico non vive quindi l’esperienza di assistere all’interazione tra il proprio genitore e un altro bambino o un’altra bambina, che sia suo fratello o sorella, quindi non può essere osservatore e giudice di un’interazione di cui necessita per la crescita: l’osservare, ad esempio, il comportamento irrazionale di un fratello che commette uno sbaglio produce “effetti liberatori” rispetto allo schema perfezionistico assunto dagli adulti con comportamenti coerenti e logici.
Essendo il figlio unico e la figlia unici esponenti esclusivi del sottosistema figliale non possono sperimentare l’appartenenza al sistema di fratelli e sorelle, è pertanto ridotta per loro l’opportunità di imparare a collaborare, a competere, a schivar o a cedere, a esprimere l’aggressività, a vincere o a perdere un’alleanza e acquisire altre capacità di vita con i propri coetanei (Minuchin, 1976).
Murray Bowen, una delle figure più importanti della terapia familiare e relazionale, parla di sistema emozionale familiare “triangolare” che comprende la madre, il padre e il figlio o la figlia: attorno a lui o lei i genitori creano un “triangolo emozionale”. Quando nella coppia si crea una forte tensione emotiva (ansia, conflittualità) che supera una certa soglia, viene spostata sul figlio o sulla figlia rendendo la tensione più sopportabile perchè distribuita su tre anzichè su due, ma spesso il carico che si prende il figlio è troppo pesante, il suo sacrificio per la tranquillità e per l’equilibrio familiare può divenire con il tempo fonte di disagio. Per salvare la coppia conflittuale ed evitare che emerga un conflitto latente il figlio o la figlia coinvolti nel triangolo possono acquistare infatti la posizione cronica di parafulmine arrivando in alcuni casi a sviluppare segni di malessere.
Risulta quindi fondamentale tenere il figlio o la figlia sufficientemente protetti da problematiche della coppia o dell’età adulta, creare occasioni extrafamiliari in cui possano sperimentare relazioni tra pari fuori e dentro casa, facendo per esempio partecipare coetanei (parenti, amici, amiche) alla vita familiare. In questo modo il figlio unico avrà la possibilità di sviluppare la sua socialità, costruire e dare un senso a legami anche al di fuori dei rapporti familiari, sviluppare sicurezza e autonomia, strutturare in modo armonico la sua personalità e differenziare il proprio sé.
Nota – Del genere e della famiglia
Nella grammatica psicologica italiana è estremamente radicato l’utilizzo inclusivo del maschile per indicare sia uomini che donne. Così nei trattati di psicologia dell’infanzia e della famiglia sistematicamente figlia e figlio diventano “Il figlio”, bambina e bambino diventano “Il bambino”. In questo articolo, in favore della ridondanza ma non in tutti i casi, si è cercato di sperimentare un linguaggio il più possibile inclusivo di entrambi i generi.
Con la consapevolezza del pericolo della semplificazione, invece, per i ruoli genitoriali si è scelto di utilizzare un linguaggio riconducibile alla famiglia composta dal padre e dalla madre. Si invitano i lettori e le lettrici a considerare la famiglia come unità affettiva fondata non sulla biologia o sulla legge ma sulla genitorialità, assunta con responsabilità e impegno quotidiano nella cura e nell’educazione, da coppie eterosessuali, omosessuali, monogenitoriali, ricostituite.
Bibliografia e sitografia
Bowen M., 1978, Family thepapy in clinical practice, New York, Jason Aronson, in BYRD Barbara – DE ROSA Arnold –CRAIG Stephen, The Adult Who is an Only Child: Achieving Separation or Individuation, in Psychological Reports 38(1993)73, 171.
Bowen M., 1979, Dalla famiglia all’individuo. Casa Editrice Astrolabio
Minuchin S., 1976, Famiglie e terapia della famiglia. Casa Editrice Astrolabio
Pitkeathkey J. Emerson D., 2011 The Only Child: How to Survive Being One. Souvenir Press
http://www.opsonline.it
http://www.famigliearcobaleno.org